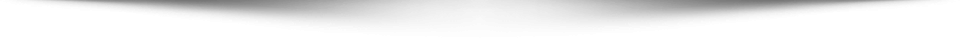Da un post Facebook di Paola Betella. Pazzesco…
di Benedetta Frigerio
Il racconto di Stephanie
“Siamo fatti per supportarci a vicenda, per prenderci per mano e accompagnarci nel viaggio della vita”. E invece? Invece Stephanie, 34enne americana, madre di quattro figli, si è vista negare le cure dopo la recente approvazione della legge sul suicidio assistito in California. La donna ha raccontato al Center for bioethics and culture (autore di diversi documentari sull’utero in affitto e sui figli dell’eterologa) la sua storia di malata terminale prima e dopo l’entrata in vigore della norma.
Anche se già l’influenza della campagna mediatica pro eutanasia, che nel 2014 utilizzò la giovane Brittany Maynard come bandiera per far leva sui sentimenti e pilotare l’opinione pubblica, aveva cominciato a cambiare la mentalità del campo sanitario. Al contrario di Brittany, la scoperta del male incurabile aveva spinto Stephanie a cercare “gruppi di supporto per questa specifica malattia”. E se prima del caso Maynard “si parlava di supporto, di amore e di aiutarsi stando lì l’uno per l’altro”, poi si cominciò a dire che “forse dobbiamo smettere di lottare (…) forse è meglio morire”, ha continuato la mamma. Poi due settimane dopo la legalizzazione del suicidio assistito, in vigore dal giungo scorso, dall’assicuarazione ”mi è arrivata una lettera che spiegava che non mi avrebbero coperto le spese sanitarie per la chemioterapia”. Volendo capire perché la donna aveva chiamato la compagnia assicurativa chiedendo se per caso il suicidio assistito era invece coperto e “sì certo”, le risposero. Dunque, “tutte le mie paure erano fondate”.
A questo punto, secondo Stephanie, il pericolo non sarebbe solo quello di indurre i malati a sentirsi di peso e quindi a richiedere la morte quasi per obbligo, ma quello che i medici stessi, le assicurazioni e l’intero sistema sanitario abbandonino i pazienti considerati inguaribili, quindi i cronici, i disabili o i terminali. E, pure in questo caso, la paura non è senza ragioni. A dimostrarlo è la Gran Bretagna con i dati del ministero della Salute che nel dicembre 2013 pubblicò la lista dei morti uccisi dal “Liverpool care pathaway”, la procedura sanitaria applicata negli ospedali inglesi per “accompagnare” i malati a morire tramite la somministrazione di sedativi, fino alla sospensione di alimentazione e idratazione: dopo la denuncia del 6 per cento delle famiglie che non erano state avvisate dai medici (in un terzo degli ospedali inglesi solo una famiglia su due viene informato del programma che porterà il loro parente a morire privato di cibo e di acqua) dell’applicazione delle linee guida, il governo aveva quindi aperto un’indagine conclusasi con 60 mila persone finite sulla lista della morte.
Ma che non sia lontana dalla realtà l’ipotesi che nel tempo l’eutanasia concepita come un diritto si trasformi in dovere di uccidere lo ha reso evidente persino la corte belga di Lovanio, che a luglio ha condannato una clinica cattolica per non aver acconsentito all’omicidio di una malata al suo interno. Erodendo sempre di più l’area dell’obiezione di coscienza che potrebbe arrivare fino all’obbligo per i medici di procurare la morte. Anche se a ben guardare basta la norma così com’è a spingere in questo senso il personale clinico senza doverlo necessariamente forzare. Come svelato dai testimoni del documentario dell’“Euthanasia Prevention Coalition” sulla tendenza in Belgio (dove l’eutanasia è legale dal 2002) a scartare i malati a loro insaputa e a quella delle loro famiglie. E come emerge dallo studio pubblicato nel 2013 dall’International Journal of Law and Psychiatry, dove si spiega che il 60 per cento dei medici belga intervistati pensa di dover decidere quando porre fine alla vita di un paziente che soffre ed è incapace di esprimere la sua volontà».
E’ quindi chiaro, conferma sempre Stephanie, che il governo, supportando “la scelta di morte di questi pazienti (…) influenza negativamente la mia vita, la mia lotta per stare più a lungo con i miei figli”. Secondo la giovane mamma viviamo in un mondo così impaurito dalla morte che tende a nasconderla, magari eliminando quanti con la loro sofferenza ci ricordano che esiste. Oppure edulcorando il linguaggio e “sovvertendo il significato delle parole”. Eppure, spiega, quando un paziente è malato ed è portato facilmente allo scoraggiamento e alla depressione la cosa di cui ha più bisogno è il supporto a combattere, fino a volere “che i miei figli vedano che morire è parte della vita. Che la fine della vita è un’opportunità di apprezzare le cose e di dire quello che non hai mai detto prima”.